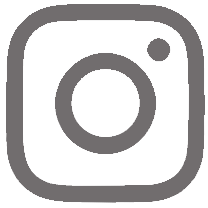I figli adottati durante la minore età acquistano la cittadinanza italiana (art. 567 c.c.; art. 3, comma 1, L. 91/1992) a decorrere dal giorno successivo al deposito o alla pubblicazione del provvedimento di adozione straniero, indipendentemente dal momento della sua trascrizione nei registri di stato civile italiani.
Trattandosi di un acquisto non iure sanguinis ma a titolo derivativo, per effetto dell’adozione, non si applicano ai figli degli adottati le norme per il riconoscimento della cittadinanza dei figli di genitori italiani per nascita. Il D.L. n. 36/2025 e la L. n. 74/2025 stabiliscono che la trasmissione della cittadinanza da parte dell’adottato, che sia titolare anche di un’altra cittadinanza, è consentita soltanto nei casi in cui i figli nascano in Italia oppure, se nati all’estero, quando il genitore abbia risieduto in Italia per almeno due anni consecutivi dopo l’acquisto della cittadinanza (art. 3 bis c. 1 lett. d della L. n. 91/1992).
Il procedimento di acquisto della cittadinanza per l'adottato prevede un'istanza di riconoscimento di effetti al provvedimento straniero di adozione (e conseguente trascrizione del provvedimento e dell’atto di nascita dell’adottato). L'ufficiale dello Stato civile verificherà che il provvedimento di adozione sia compatibile con i principi di ordine pubblico italiani (secondo la normativa italiana all'epoca vigente) e lo trascriverà nei registri di nascita, trascriverà inoltre l’atto di nascita dell’adottato e emetterà un'attestazione di acquisto della cittadinanza italiana (da formulare ad hoc per il caso di specie) ex art. 3, comma 1 legge 241/1990 e 16 c. 8 D.P.R. n. 572/1993, con annotazione a margine dell’atto trascritto dell’adozione e dell’acquisto della stessa cittadinanza.
(v. S. Arena, Lo Stato civile italiano, ottobre 2022, pag. 28, ss.)
| . |
| . |
Cittadinanza Iure Sanguinis
In base agli articoli 1 e 3bis della Legge 91 del 1992, acquista automaticamente la cittadinanza italiana per discendenza:
· Chi è nato in Italia da un genitore con cittadinanza Italiana;
· Chi è nato all’estero ed ha un genitore o un nonno in possesso della sola cittadinanza italiana. (art. 3bis c. 1 lett. c).
· Chi è nato all’estero da un genitore che ha la cittadinanza italiana ed è stato residente in Italia per almeno due anni continuativi, come cittadino italiano, prima della nascita del figlio. (art. 3bis c. 1 lett. d).
Inoltre può acquisire la cittadinanza italiana:
· chi è nato all’estero da un genitore italiano per nascita che possiede anche un’altra cittadinanza, se il genitore ne dichiara la volontà e il figlio risiede in Italia per almeno due anni continuativi dopo tale dichiarazione (art. 4 comma 1bis lett. a);
· chi è nato all’estero da un genitore italiano per nascita che possiede anche un’altra cittadinanza e il genitore dichiara entro un anno dalla nascita, la volontà che il figlio la ottenga (art. 4 comma 1bis lett. b);
Norme specifiche disciplinano il caso dei figli adottivi.
In questi casi l’acquisto della cittadinanza è automatico e produce effetti a partire dalla nascita dell’interessato.
Altri modi di acquisire la cittadinanza italiana
Per beneficio di legge: i figli nati all’estero da un genitore italiano per discendenza, se non sono in possesso dei requisiti per l’ottenimento della cittadinanza italiana in via automatica, possono ottenere la cittadinanza italiana se i genitori o il tutore dichiarano la volontà dell’acquisto.
IMPORTANTE questa possibilità è esclusivamente per i figli di italiani per discendenza, non si applica ad esempio ai figli di genitori riconosciuti italiani attraverso la legge 379/2000.
Per nascita in Italia da genitori ignoti o se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello stato di appartenenza; inoltre lo straniero (maggiorenne) nato in Italia può ottenere la cittadinanza dopo tre anni di residenza.
Per matrimonio (iuris communicatio, art. 5) con cittadino/a italiano/a, dopo due anni di residenza in Italia o tre anni all’estero. I termini sono ridotti alla metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi. (art. 5 comma 2 L. 91/1992).
IMPORTANTE: le donne che hanno sposato cittadini italiani prima del 27 aprile 1983 hanno acquisito automaticamente la cittadinanza italiana. Fino a tale data la donna straniera che contraeva matrimonio con un cittadino italiano acquisiva la cittadinanza italiana e la conservava anche dopo la morte del marito. (art. 10 della legge 13 giugno 1912 n. 555)
Per naturalizzazione (o concessione, artt. 4 e 9) nei seguenti casi:
o straniero di cui un genitore o un/a nonno/a sia stato cittadino italiano (i.e. prima della sua nascita), dopo tre anni di residenza in Italia, oppure a seguito di servizio militare o svolgimento di pubblico servizio presso lo Stato italiano;
o straniero che presti servizio alle dipendenze dello Stato per almeno cinque anni;
o cittadino dell’Unione Europea, dopo quattro anni di residenza in Italia;
o straniero che risiede in Italia per almeno dieci anni.
Per elezione, in base ai trattati firmati dall’Italia in seguito ai conflitti bellici, con riguardo alle popolazioni di lingua ed etnia italiana provenienti dai territori ceduti e nelle colonie in Africa e nell’Egeo, fra i quali:
o Trattato di Saint Germain-en-Laye del 10 settembre 1919 con l’Austria;
o Trattato di Parigi firmato il 10 febbraio 1947 con le Potenze alleate;
o Trattato di Osimo del 10 novembre 1975.
La legge riconosce il diritto ad ottenere la cittadinanza italiana a coloro che si trovano nella situazione considerata in questi trattati e ai loro discendenti. Per i discendenti dei cittadini italiani che erano residenti nei territori italiani ceduti alla Repubblica Jugoslava in forza del Trattato di pace firmato a Parigi il 10 febbraio 1947 (art. 19) e del Trattato di Osimo del 10 novembre 1975 (articoli 17bis e 17 ter della legge n. 91/1992).
IMPORTANTE: I discendenti degli emigrati dal Trentino e dagli altri territori dell’Impero Austro-Ungarico prima del 16 luglio 1920, hanno potuto riacquistare la cittadinanza italiana soltanto nel periodo dal 2000 al 2010 con la legge 379/2000.
Per loro non è più possibile richiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana.
| . |
| . |
La cittadinanza: come si riacquisisce?
- In modo automatico (senza alcuna manifestazione di volontà), se la persona che ha perso la cittadinanza risiede in Italia per un anno (art. 13, comma 1 lettera d, legge n. 91/1992), o risiede per due anni e dimostra di aver lasciato l’impiego o il servizio militare (per i casi in cui lo Stato italiano ne abbia ordinato l’abbandono, art. 13, c. 1 lettera e);
- con una manifestazione di volontà (dichiarazione) entro il 31 dicembre 2027, anche senza trasferirsi in Italia, per chi è nato in Italia e vi è stato residente per almeno due anni consecutivi e ha perduto la cittadinanza prima del 15 agosto 1992 per averne acquisita un'altra ed essersi trasferito all'estero (art. 17 L. 91/1992 modificato dalla L. n. 74/2025 e art. 8 numeri 1 e 2 o art. 12 L. 555/1912);
- con una manifestazione di volontà (dichiarazione), dopo aver prestato il servizio militare o un impiego per lo Stato italiano (art. 13, comma 1 lettere a e b);
- dichiarando di voler riacquisire la cittadinanza italiana e di stabilire la residenza in Italia entro un anno dalla dichiarazione (per i residenti all’estero, art. 13 comma 1 lettera c). La dichiarazione si può presentare in Italia presso il Comune di residenza, oppure all’estero, presso il Consolato italiano. In quest’ultimo caso, avrà effetto solamente dopo aver registrato la residenza in Italia e dopo che il Comune di residenza in Italia avrà ricevuto la dichiarazione dal Console italiano;
- con un'istanza al Comune o al Consolato italiano competente per la zona di residenza, documentando di essere stati cittadini italiani residenti nei territori facenti parte dello Stato italiano successivamente ceduti alla Repubblica Jugoslava in forza del Trattato di pace firmato a Parigi il 10 febbraio 1947 (Trattato di Osimo del 10 novembre 1975), e di non essersi avvalsi della facoltà riconosciuta dall’art. 3 del Trattato di Osimo di trasferire la residenza dalla zona B dell’ex territorio libero di Trieste nel territorio italiano. Tali cittadini hanno perso la cittadinanza italiana in virtù dell'acquisizione volontaria di quella jugoslava (articoli 17bis e 17 ter della legge n. 91/1992).
La cittadinanza: Come si perde?
I cittadini italiani possono perdere la cittadinanza:
· Per manifestazione di volontà (rinuncia), se acquistano la cittadinanza di un altro Stato (articoli 11, 14, 3 c. 4 legge 91/1992);
· per sanzione, in caso di disobbedienza all’ordine dello Stato italiano di abbandonare un impiego pubblico, una carica o il servizio militare presso uno Stato straniero (art. 12 legge 91/1992);
· per legge, in base alla Convenzione di Strasburgo sulla riduzione dei casi di cittadinanza plurima del 6 maggio 1963, per coloro che acquisiscano la cittadinanza di alcuni Stati che non ammettono la doppia cittadinanza o la limitano a specifiche condizioni. I Paesi e le condizioni cambiano spesso, è pertanto necessario verificare bene la situazione specifica, prima di richiedere o acquisire una seconda cittadinanza. La perdita della cittadinanza avviene anche per i figli minori, nel caso in cui entrambi i genitori rinunciassero;
Caso particolare: non hanno perso la cittadinanza italiana i figli degli emigrati italiani, nati all’estero fra il 27 aprile 1965 e il 17 maggio 1967, che non hanno fatto una scelta espressa per la cittadinanza italiana nel periodo di transizione fra il vecchio ordinamento e il nuovo entro il 17 maggio 1986, come disposto dall’art. 5, legge n° 123 21 aprile 1983.
Vedi a proposito l'approfondimento: La doppia cittadinanza.
I Comites sono organismi rappresentativi della collettività italiana presso le sedi consolari. I Comites sono eletti direttamente dai residenti all'estero in ciascuna circoscrizione consolare ove risiedono almeno tremila connazionali iscritti AIRE. In circoscrizioni ove risiedono meno di tremila cittadini italiani i Comitati possono essere nominati dall'Autorità diplomatico-consolare.
I Comites sono composti da 12 membri o da 18 membri, a seconda che vengano eletti in Circoscrizioni consolari con un numero inferiore o superiore a 100 mila connazionali. Oltre ai membri eletti di cittadinanza italiana, possono far parte del Comitato, per cooptazione, cittadini stranieri di origine italiana.
Il compito dei Comites è rappresentare le istanze della collettività italiana di fronte alle autorità diplomatiche consolari, di promuovere iniziative culturali e ricreative per gli italiani residenti nel territorio di competenza e in generale di collaborare con il Consolato nell’organizzazione di attività e nella tutela di interessi e diritti degli Italiani.
Le ultimi elezioni per il rinnovo e l’istituzione dei Comites si sono tenute il 3 dicembre 2021.
Le sedi dei comitati attivi alla data attuale si trovano in Europa (47), nelle Americhe (42), in Asia e Oceania (10) e in Africa (7). Consulta qui l’elenco completo.
Per ulteriori informazioni rivolgiti alle rappresentanze diplomatiche italiane della tua area consolare.
Guarda questi video per maggiori informazioni sulle funzioni dei Comites e sulle elezioni che si sono svolte il 3 dicembre 2021.